Qualche volta il rifiuto del cibo non è sintomo del male di vivere, ma una conseguenza del cercare di
adeguarsi a tutti i costi a dei canoni di bellezza che qualcun altro ha deciso per noi. Imporre dei modelli
estetici spesso irraggiungibili è uno dei modi tramite i quali non il singolo, stavolta, ma la società intera
esercita il controllo. Una società surrettiziamente impersonata da un apparato economico che crea i nostri
bisogni e ci indica la maniera per soddisfarli, passando sempre e comunque per il corpo della donna:
anche il mondo maschile ha i suoi canoni di bellezza, ma sono un po’ meno stringenti. Non sto dicendo
che per un uomo brutto la vita sia tutta rose e fiori, ma credo di essere obiettivo se affermo che alcuni
traguardi che per la donna dipendono in primis dalla sua avvenenza sono più facilmente abbordabili da un
uomo a prescindere dal suo aspetto fisico (per esempio in ambito lavorativo).
Le protagoniste di “H2Odio” (2006) di Alex Infascelli sono donne e sono convinto che la stessa storia
incentrata su degli uomini non avrebbe funzionato altrettanto bene, anzi non avrebbe funzionato affatto,
mancando delle premesse psicologiche per rendere tutto plausibile. Perché una cosa va detta: pur con i
suoi numerosi difetti, il film riesce a mio parere a suscitare un reale senso di disagio, e se anche non
intendeva trasmettere chissà quale messaggio o insegnamento, questo ci arriva ugualmente.
Ma veniamo
alla trama. Cinque amiche che vogliono sperimentare un digiuno di una settimana si recano tutte assieme
nella vecchia casa di famiglia di una di loro, Olivia. Lo scopo è non avere distrazioni né tentazioni di sorta
e l’ubicazione della casa, su un’isola in mezzo a un lago, è l’ideale. Anche chi ha poca o nessuna
esperienza intuirà che un digiuno di una settimana è piuttosto estremo, e che assumere farmaci mentre si è
a digiuno è una pessima idea, ma il più grosso problema è che ben presto anche le scorte d'acqua
spariscono, il che ha gravi ripercussioni, anche mentali, sulle ragazze. La situazione degenera alla
rivelazione che quella che sembrava la più convinta a fare questo esperimento, Olivia, è anche la più
provata dall’esperienza: la ragazza è soggetta alla sindrome del gemello scomparso, una condizione che la
porta a isolarsi e a sentire la presenza del fantasma della sorella gemella.
C’è una vaga possibilità che
questa sorella sia solo il frutto di una mente disturbata, ma poco importa: la conclusione tragica (siamo in
un horror) andava pur giustificata in maniera più articolata di un’estemporanea follia senza senso, e la
concomitanza della privazione di cibo e di un trauma irrisolto sembra proprio il movente perfetto.
Basta osservare come la donna veniva raffigurata in molte famose opere d’arte del passato per rendersi
conto che la relazione tra magrezza è bellezza è un fenomeno moderno: nell’antichità le forme ideali
erano morbide e avvolgenti. Negli ultimi anni si sta però affermando una tendenza opposta: sotto l’egida
della "body positivity" si tende a fare un vanto di corpi oggettivamente sovrappeso, anche in maniera
esagerata e poco sana. Mi domando quando e se si troverà mai la corretta via di mezzo fra l’attenzione per
l’immagine e la necessità di avere un corpo sano e in salute, prima che “bello” e “alla moda” (concetti
quanto mai evanescenti e soggetti alla revisione del tempo, da qui il senso delle virgolette).
Ad ogni modo, se essere obesi può essere un vanto per le persone famose o per chi calca le passerelle,
nella vita di tutti i giorni le cose sono ben diverse.
Come l’estrema magrezza, anche l’obesità è spesso un
deterrente alla vita sociale, oltre al fatto che rende difficoltosi a chi ne soffre tutta una serie di gesti che
per i normopeso sono banali e scontati: alzarsi, sedersi, fare le scale, e così via. È un tema spinoso,
imbarazzante, spesso trascurato dal cinema. Ricordo, a memoria, “Precious”, film del 2009 diretto da Lee
Daniels, dove però l’obesità della protagonista è soltanto un fatto accidentale, messo del tutto in ombra
dal fatto che la ragazza è semianalfabeta, abusata, messa incinta e resa sieropositiva dal padre. Forse
accidentale non è il termine giusto, dato che la popolazione nera è in effetti quella più soggetta a problemi
di obesità, almeno negli Stati Uniti, ma ci torneremo su più avanti. So che molti non saranno d’accordo
con quanto sto per dire, ma questo film mi sembra in qualche modo incompiuto: ha fallito nell’intento di
toccare le mie corde più profonde, non mi ha reso davvero partecipe, non mi ha fatto soffrire. Vai a sapere
perché. Forse, semplicemente, la somma delle sfighe di questa ragazza mi ha anestetizzato.
Oggettivamente, resta il fatto che quella della protagonista non è una condizione eccezionale nel suo
ambiente di provenienza, e la sua obesità non è il prodotto di un trauma psicologico come, ad esempio,
nel caso di Charlie nel lungometraggio di Darren Aronofsky “The Whale” (2022), che con questo film si
riconferma regista straordinario.
“The Whale” è un dramma da camera (è infatti l'adattamento di un'opera
teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter) girato in un formato 4:3 che sembra scelto apposta per far
risaltare ancora di più le dimensioni elefantiache del protagonista; un dramma dal sapore apocalittico dove
il sole torna a splendere (non solo in senso metaforico) solo nel lirico finale. Aronofsky sceglie un
Brendan Fraser appesantito dai chili di troppo e, nell’immaginario hollywoodiano, attore fallito e
destinato all’oblio (anche se io trovo che sia ancora oggi uno splendido signore e un ottimo attore e, del
resto, il suo Oscar per questo ruolo parla chiaro), cioè un attore in cerca di riscatto per interpretare un
uomo in cerca di redenzione; e gli regala il ruolo della vita.
La storia di Charlie, diventato obeso a seguito
della perdita del compagno Alan, per il quale aveva abbandonato moglie e figlia, è una lunga riflessione
sul dolore, dove il peso del corpo è la materializzazione del peso dell’anima e, forse, anche di quello della
colpa. Il film naturalmente tocca anche altri temi, in primis quello della solitudine nell’era dei social
media (e qui una considerazione su quanto sia semplice mascherare la realtà sui social ci sta tutta), ma anche la religione e le scelte personali, oltre che la legittimità di riscattare il passato scaricando su altri il peso delle proprie azioni;
mi spiegherò meglio in seguito, ora occorre addentrarsi nella trama.
Charlie vive gran parte della vita sul
divano di casa, da dove tiene le sue lezioni di inglese on-line (rigorosamente a telecamera spenta) e da
dove scambia qualche parola con la sua unica amica Liz, spiaggiato come un cetaceo ingannato dai sensi.
Ma il titolo del film non è un’allusione greve al peso di Charlie, perché la storia è una rivisitazione del
celeberrimo romanzo di Melville “Moby Dick”, dove la lotta vede però contrapporsi Charlie e sua figlia
Ellie, oggi diciassettenne, un’adolescente problematica che l’uomo non vede da quasi nove anni. Appreso
che non gli resta molto da vivere, Charlie tenta infatti un riavvicinamento con Ellie, che però accetta di
passare del tempo con lui solo quando il padre le offre in cambio i 120 mila dollari che ha in banca (in
realtà già messi da parte da tempo e comunque destinati a lei) con i quali l’uomo spera di fare almeno una
cosa buona nella vita.
La guarigione spirituale di Charlie è, come sempre avviene, un processo che
prevede la caduta prima della risalita; lo vediamo quindi vergognarsi del suo aspetto, ingozzarsi a
dismisura e poi vomitare; lo vediamo mostrarsi per la prima volta ai suoi studenti; lo vediamo infine
narrare la morte di Alan e svelare così l’ipocrisia della religione (Alan, la cui famiglia apparteneva a una
setta religiosa, si era suicidato a causa del senso di colpa causato dalla sua omosessualità).
E Ellie? Come
il capitano Achab, che odia il capodoglio perché lo ha ferito e lo vede come l’incarnazione del male,
anche Ellie odia il padre e desidera fargli del male, forse perfino vederlo morto. Nelle parole di Ellie, il
cetaceo “è soltanto un povero, grosso animale” mentre Achab “crede che la sua vita sarebbe migliore se
riuscisse a uccidere la balena, ma in realtà non l’aiuterà affatto”; e la descrizione è perfettamente
sovrapponibile a padre e figlia. La furia di Ellie è la furia di Achab, ma neppure lei trarrà conforto dalla
sofferenza e dalla morte del padre. Perché ci sono certo molti motivi per disprezzare Charlie, ma
altrettanti per amarlo.
Resta, alla fine, un grande interrogativo, ovvero come potrà la psiche già devastata
di Ellie reggere il peso della consapevolezza del sacrificio estremo che il padre ha fatto per lei,
interrogativo che, come i migliori registi sanno fare, Aronofsky consegna a noi poveri e affranti spettatori.
Per concludere in leggerezza, dopo questa immersione nel dramma più totale, voglio ricordare anche il
protagonista di un segmento di “Taxidermia” (György Pálfi, 2006), film grottesco a episodi che approda
nel body horror, di cui avevo già parlato brevemente nel 2019. Di queste tre
storie, che rappresentano tre generazioni non solo nel senso familiare (padre, figlio e nipote), ma anche
storico (la seconda guerra mondiale, il periodo comunista e post comunista) a interessarci è quella
centrale, che vede Kálmán Balatony partecipare ad allenamenti e gare di abbuffata con vomito, a quanto
pare molto popolari nei paesi comunisti – ove la bulimia, disturbo alimentare molto diffuso fra gli
sportivi, viene elevato a sport.



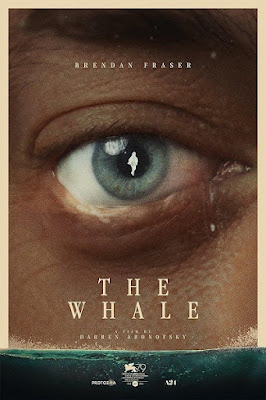


Tutti parlano bene di "The whale", mi viene proprio il desiderio di vederlo anche per la curiosità di vedere Fraser in un ruolo che apparentemente (visti i film che ha girato nella prima fase della sua carriera) non era per niente adatto a lui.
RispondiEliminaIo ho atteso a lungo prima di vederlo, sapevo che sarebbe stato emotivamente impegnativo e così è stato... però merita, assolutamente, e a posteriori non mi viene in mente un altro attore che avrebbe saputo interpretare quel ruolo altrettanto bene.
Elimina